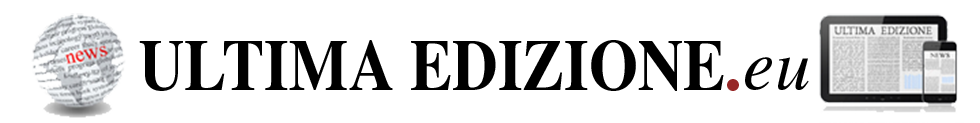Il Pnrr, il ministro Giorgetti e il rischio di tornare a cinquant’anni fa – di Roberto Pertile

Malgrado appaia ai più un’assoluta novità, la lettura del” Piano di ripresa e resilienza” (Pnrr), redatto dall’Italia per partecipare alla ripresa economica e sociale dell’ Europa , in risposta ai danni provocati dalla pandemia, mi fa tornare indietro di cinquant‘anni.
Anche allora, le idee, i progetti, i programmi furono tanti, pensati per trasformare una società ; e i tecnici si misero al tavolino per dare concretezza all’utopia di un ‘Italia moderna, europea , non fascista, che voleva vivere leggendo i grandi scrittori stranieri, banditi fino a qualche decennio prima., immergersi nella musica targata Usa , visitare i musei di questa splendida Europa, scoprire la “ London Economics School” . Leggendo il PNRR sembra che il tempo, per uno strano sortilegio, si sia fermato.
Negli anni ’60, c’era stato, in Italia, il miracolo economico; bisognava far seguire a quella fase entusiasmante di crescita un salto di qualità : erano necessarie nuove strutture amministrative e tanta innovazione tecnologica. I documenti programmatici , coordinati da Giorgio Ruffolo, allora Segretario Generale della Programmazione Economica, erano ricchi di proposte operative. La sfida digitale di quegli anni aveva un nome: il Gruppo Olivetti, dotato della più capillare rete di vendita mondiale, temuto moltissimo dalle grandi Corporations.
Non solo il mondo aziendale, ma l’Italia tutta dovevano realizzare il difficile salto tecnologico dalla meccanica all’elettronica, nonché vincere la concorrenza spietata degli operatori statunitensi, che, ancora oggi, dominano il mercato. L’operazione implicava l’assunzione di un rischio molto alto e con i tempi del ritorno economico non brevi.
Era una ” sfida Paese.” E la risposta del Sistema Italia fu assai reticente. La Finanza, con Mediobanca capofila, disse che i “Canavesi”( l’Olivetti di Ivrea e dintorni) non erano portati per tutto ciò che non fossero macchine da scrivere. Così, gli industriali, a cominciare dalla Fiat: ma cosa si sono messi in testa quelli dell’Olivetti? Vogliono andare a fare concorrenza al mercato statunitense? In altri termini, un ‘Italia pavida e miope, oggi diremmo di serie B.
Gli investimenti ad alto rischio tecnologico non sono mai stati di grande gradimento nella classe dirigente italiana: negli anni cinquanta eravamo il primo paese europeo nel nucleare… Poi, il tutto è stato svenduto agli Usa, in omaggio al clientelismo politico dei partiti.
Un documento di programma fondamentale per i futuri assetti industriali e sociali è stato il Piano IRI-Stet per l’elettronica degli anni ottanta/novanta. È utile ricordare l’esperienza attuativa di questo programma, alla luce dei possibili ragionamenti da fare sulla realizzazione del Pnrr.
A guida Stet, l’industria italiana delle telecomunicazioni, in prima linea con l’azienda italiana Seat-Siemens, avrebbe dovuto diventare autonoma dall’industria tedesca nella R&S e dare vita ad un indotto di produttori di apparecchiature elettroniche che avrebbe favorito la trasformazione dell’industria italiana da prevalentemente meccanica ad elettronica. Al di là delle dichiarazioni governative , prevalse la logica di investire in prodotti di consumo ad immediato profitto. È stato , così, accumulato un ritardo tecnologico incolmabile.
Non solo gli industriali , ma neppure la dirigenza della Pubblica Amministrazione furono favorevoli a un modello di investimenti organici a medio/ lungo periodo.
Emblematico è il caso di una delle più grandi imprese al mondo, che aveva deciso di impegnare risorse in Italia, come mai prima, in campi di tecnologia d’avanguardia. Il Presidente del Consiglio Italiano, a quel tempo in carica, e il ”n 1 “ dell’Azienda si accordarono su tempi , modalità e procedure, non tenendo però conto che l’assenso al progetto da parte del “ premier” italiano contava, allora, assai poco. Infatti, il piano dell’impresa prevedeva di iniziare, munita di tutte le autorizzazioni, gli investimenti nell’arco temporale di un paio di mesi. La risposta del Ministero competente di allora, è stata, invece, che,, in base al protocollo ministeriale interno, il piano della Corporations sarebbe stato esaminato dagli uffici ministeriali non prima di un anno. Gli investimenti vennero fatti in un altro paese europeo . Il benessere di migliaia di lavoratori italiani non faceva parte del protocollo ministeriale.
Leggendo il PNRR, cresce la convinzione che malgrado siano passati cinquant’anni , non è venuta meno la debolezza strutturale della politica industriale, che non ha mai avuto nella R&S il suo epicentro. È rimasta inascoltata, infatti, l’insistenza, presente nei documenti di programmazione degli anni 60/70, sul ruolo strategico della R&S nell’impresa e sulla miopia imprenditoriale che riteneva sufficiente acquistare in Germania, preferibilmente, macchinari con incorporata l’innovazione di processo, delegando al basso costo della manodopera la competitività del prezzo del prodotto, che consentiva di realizzare subito profitti elevati. Non è cambiato molto, salvo casi rari di eccellenza e di singoli cambiamenti imposti dal mercato globale.
È la logica del breve termine, che nei fatti continua a prevalere, nonostante “i libri bianchi ”che pontificano l’opposto. Nella realtà della contrattazione salariale, le parti sociali non accettano il modello della crescita programmata concordata tra le parti sociali. Di fatto, viene esclusa la via per una nuova società.
Attualmente, come anche allora, si è di fronte ad un cambiamento del sistema della produzione: ieri, il passaggio dalla catena di produzione fordista ai nuovi sistemi giapponesi e alla ”lean production” (cioè, alla produzione snella e senza sprechi). Oggi, si ha un passaggio fondamentale: la transizione digitale, ecologica e la rivoluzione dell’intelligenza artificiale.
Quale insegnamento per il presente possiamo trarre dalla particolare analogia col passato per non fallire ancora? Il disegno programmatico degli anni 60/70 non fu condiviso dai Sindacati, appoggiati dal Pci. Significava realizzare un’intesa di medio/ lungo periodo su una politica dei redditi del lavoro e del capitale.
Non ci fu una politica dei redditi; anzi, per la pace sindacale vennero concordati, soprattutto negli anni’70 , aumenti salariali, non compatibili con la competitività del sistema Italia. Di fatto sono stati dati sussidi per la tutela del posto di lavoro anche a discapito del fattore lavoro, l’unico che garantisce benessere a medio termine. Così, per effetto di questa logica, si è giunti allo smantellamento di gran parte dell’industria pubblica.
Il piano del “premier” Draghi, non molto dissimile, nelle logiche di fondo, da quello di Ruffolo, riuscirà a vincere la logica corporativa e assistenziale, che si è incardinata in questi cinquant’anni nel tessuto sociale italiano?
È opportuno insistere nell’evidenziare che gli industriali italiani hanno creduto molto poco nelle operazioni di concertazione programmata dello sviluppo della produzione e del mondo del lavoro. Non sono stati una forza propulsiva per il governo dell’innovazione e della competitività del sistema. Hanno preferito speculare sulla domanda pubblica interna o beneficiare degli incentivi pubblici in c/interessi, nonché delle agevolazioni all’export.
A sentire le recenti dichiarazione del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti ( CLICCA QUI ), il tempo della politica industriale sembra anche qui proprio fermo: gli industriali (novità) chiedono sussidi; non sono molto interessati ai centri di R&S, alla formazione professionale permanente del personale, ad una diversa gestione della domanda pubblica di beni e servizi. Meglio i soldi subito .
Si ripropone il tema della qualità del Capitale italiano. A questo proposito, nella storia economica e politica italiana, c’è da ricordare il fallimento della nazionalizzazione dell’energia elettrica. Uno degli obiettivi dell’erogazione di flussi finanziari molto elevati alle imprese era quello dell’allargamento della base produttiva, soprattutto con imprenditori privati. Ciò non accadde: la speculazione finanziaria fu preferita all’economia reale. E’ da allora che si invocano processi di ricapitalizzazione delle imprese nazionali con scarso successo.
Dunque, con il Governo Draghi, grazie al Pnrr, ci sarà un’inversione di tendenza? Il Ministro Giorgetti, d’accordo con Confindustria, rivedrà le sue idee in materia di sussidi, che aboliscono la prosperità e non la povertà?
La non felice uscita giornalistica del Ministro Giorgetti ci ha fatto ricordare che sono ancora ben presenti le forze sociali ed economiche che hanno contribuito, in misura determinante , al fallimento di un disegno pluriennale di cambiamento strutturale degli assetti economici e sociali dell’ Italia degli anni 60/70. Per cui, evidenziare quanto è successo in passato è funzionale a non perdere un’altra battaglia per il Bene Comune dell’Italia, come potrebbe avvenire con il Pnrr.
Roberto Pertile